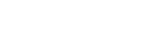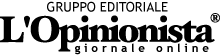Che cos’è il teatro?
“Uno specchio che riflette, corretta e normalizzata, la realtà deformante della platea”.
Vuol dire che i copioni li scrivono gli spettatori?
“Li scrivi anche tu. La gente di strada, i clienti in un ristorante, i sani e i malati, gli ignoranti e i geni. Noi siamo i loro replicanti, cerchiamo d’indorare l’umanità”.
C’è gente che vi invidia.
“E noi invidiamo loro, la loro normalità, gli orari giusti: l’ufficio, la pausa, il ritorno a casa, la televisione dopo cena, la buonanotte a qualcuno che ti sta vicino”.
Parli come un disperato.
“Ma noi attori lo siamo disperati. Diderot diceva che siamo dei sacchi vuoti che vengono riempiti ogni volta con un personaggio diverso. Finito lo spettacolo, ci svuotiamo, cadiamo a terra senza forze. Eppure l’attore arriva a intuire prima di chi sta in platea, e arriva a trasformare il ricordo in futuro: e a proiettare all’orizzonte parole scritte mille anni fa”.
Siete dei profeti.
“Siamo gente senza tempo. Abbiamo il compito di suonare l’allarme. Segnaliamo il pericolo di diventare robot. Il pericolo di non emozionarsi, di non sapere più distinguere un rumore da una nota musicale. Ecco, siamo degli orchestrali delle parole, proviamo a fare cantare la vita anche a chi è stonato, chi è pigro non vuole usare le corde d’uno strumento misterioso che ha dentro di sé”.
Perché vi truccate?
“Per somigliare di più a voi. Voi che dite di non volere essere protagonisti, e che in realtà recitate uno, cento, mille ruoli diversi e contrastanti. Nemmeno il regista più smaliziato, riuscirebbe a stare dietro alle vostre follie, ai vostri giochi di parole e di maschere”.
Raccontami un episodio, un’emozione da non dimenticare del tuo teatro.
“Il palcoscenico non è soltanto quello fatto di tavole di legno o di riflettori. Noi attori vorremmo recitare ovunque. Davanti anche a un solo spettatore. Basta ingannare un solo pagante, per giustificare uno spettacolo di ore, una fatica infinita. Ti racconto del funerale di un amico. Ernesto Calindri. Un attore morte molto anziano. Avevo recitato con lui in una parte secondaria, in un teatro di Milano, Capocomico in scena, era capocomico anche il giorno del suo funerale. Tutti intorno a lui, dovevamo raggiungerlo nella chiesa di San Babila alle nove in punto. Lui era preciso, e pretendeva precisione anche dagli altri della compagnia. Ecco, quella mattina mi sono alzato presto e ho cominciato a pensare: come mi vesto? Mi metto un abito di lino, magari chiaro? Oppure una giacca blu con una cravatta malinconica? Oppure così, mi butto addosso una maglietts sportiva ma scura? Insomma, senza volerlo, cercavo il protagonismo. Andavo a quel funerale come a una rappresentazione: e volevo farmi notare. Volevo rubare un’emozione a quella bara di legno ai piedi dell’altare attorniata da rose rosse. Poi ho scelto un vestito grigio, ma non troppo malinconico. La giacca mi stava un po’ stretta, era due anni che non l’indossavo. La cravatta, a strisce blu e rosse. Un tocco di profumo, sulle tempie. Lui, il vecchio Ernesto, adorava il profumo in camerino. Profumiamo il palcoscenico, e che il profumo arrivi fino alle prime file della platea.
Lo ripeteva simpaticamente ogni sera. E così quella mattina arrivai puntuale all’appuntamento con quella bara, con quelle rose rosse. Pensavo che qualcuno avrebbe notato il mio vestito grigio, la mia cravatta a strisce. E anche respirato il mio profumo, incuriosito. La chiesa era già affollata. C’erano le telecamere che stavano riprendendo le autorità in prima fila, il sindaco, i figli dell’attore. Adesso qualcuno si accorgerà di me, pensai. E camminavo in mezzo alla chiesa, aspettando qualche sguardo. Nulla. Passavo inosservato, perché tutti gli occhi erano puntati su quella bara, tutte le bocche respiravano quelle rose rosse. In quegli istanti, passo dopo passo, dal portone d’ingresso, fino a pochi metri dalla bara, ho subito l’umiliazione più forte della mia vita. Ero un signor nessuno, altro che un attore truccato e affascinante, impegnato in un ruolo che potesse aiutare gli altri, smascherandoli. Annullato, di fronte al primo attore che anche da morto mi surclassava. Così, ho voltato le spalle a Calindri, e sono tornato sui miei passi, fino all’uscita. Una volta all’aria aperta, mi sono mischiato tra le folla del centro di Milano. Tra le gente semplice, che non ha mai avuto la forza o la debolezza di salire sul palcoscenico, di recitare un copione. Già, un copione. Dopo quel funerale, non riesco a trovare un copione in cui possa, per un istante, sentirmi protagonista. Qualcuno me lo scriva, per favore”.
Che autore vorresti, chi potrebbe inventare le parole giuste per ridarti fiducia e forza per un domani?
“Potrei farti dei nomi importanti, ma ce n’è uno che è pronto a scrivere quel copione. Sono io. Per la prima volta io. E ti dico che il lavoro comincerà proprio da quella scena del funerale. Da lì, dai mesi passi che tornano verso il portone della chiesa, dalla mia uscita tra la gente. Da quei momenti comincerà il mio copione. E lo reciterò tutte le sere, da qui a sempre”.