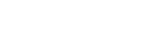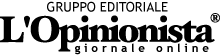Dalle sentenze shock alla lezione europea sulla violenza di genere: il caso di Macerata e il ritorno del “pregiudizio morale”

Nel primo processo, la motivazione dell’assoluzione aveva destato sdegno: si sosteneva che la vittima “non fosse vergine” e quindi “consapevole di ciò a cui andava incontro”. Una giustificazione che trasforma la vita sessuale pregressa di una donna in un elemento probatorio di consenso, un’idea che la Convenzione di Istanbul e la giurisprudenza europea hanno da tempo definito come discriminatoria. La Corte d’Appello ha ribaltato quella logica, restituendo dignità al concetto di consenso e ricordando che nessun comportamento, abbigliamento o relazione pregressa può mai costituire un’autorizzazione implicita alla violenza.
Non è certo la prima volta che la giustizia italiana inciampa su pregiudizi patriarcali. Nel 1999 la cosiddetta “sentenza dei jeans”, poi annullata dalla Cassazione, sostenne che lo stupro non potesse essere avvenuto perché la ragazza indossava jeans “troppo stretti” per essere tolti senza il suo consenso. Sentenze di questo tipo mortificano la dignità delle donne, costrette a processi estenuanti, e a subire una vera e propria vittimizzazione secondaria, in cui vengono giudicate più che tutelate.
Un altro caso emblematico è quello accaduto ad Ancona nel 2015, quando due uomini furono inizialmente assolti perché la vittima sarebbe stata “troppo mascolina per subire uno stupro”. Una tesi aberrante, accolta da una Corte d’Appello che scambiò il pregiudizio per argomento giuridico. Solo anni dopo, nel 2020, la Corte di Perugia ristabilì la verità, e nel 2024 la Cassazione rese definitiva la condanna. Quella frase, “troppo mascolina”, è diventata simbolo di una giustizia che, invece di interrogare la violenza, interroga il corpo delle donne.
Altro episodio più recente che ha suscitato sdegno è la sentenza del Tribunale di Roma che ha assolto un operatore scolastico accusato di aver toccato i glutei di una studentessa per pochi secondi.
Nelle motivazioni, i giudici riconoscono che il gesto “integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale”, trattandosi di un toccamento di una zona erogena senza consenso. Tuttavia, l’assoluzione è arrivata perché, secondo il Tribunale, la brevità dell’azione, “quasi uno sfioramento”, e il contesto pubblico “non consentivano di configurare un intento libidinoso”.
L’episodio è stato quindi derubricato a “atto scherzoso inopportuno”, nonostante la stessa sentenza ammetta che la natura scherzosa non esclude, in astratto, il dolo richiesto dalla legge. In sostanza, la violenza è stata riconosciuta ma non punita: dieci secondi non sono bastati a configurare una molestia.
Una motivazione che riapre la ferita del linguaggio giudiziario e del suo rapporto con la cultura della minimizzazione: se il tempo o il contesto diventano attenuanti, si rischia di trasformare l’aggressione in malinteso e la vittima in soggetto esagerato o inaffidabile.
Un’analoga distorsione si riscontra nella vicenda di Lucia Regna, aggredita a Torino dall’ex marito nel luglio 2022, che la colpì con violenza devastante fratturandole il volto, causandole danni permanenti alla vista e costringendola a 40 giorni di prognosi. Nonostante la gravità dei fatti, l’uomo è stato assolto dall’accusa di maltrattamenti e condannato soltanto per lesioni personali (un anno e sei mesi con pena sospesa). Nelle motivazioni, il giudice ha parlato di “sfogo d’ira”, di “amarezza per la dissoluzione del matrimonio” e di un uomo che “va compreso”. Parole che pesano come un macigno: ricondurre la brutalità alla fragilità emotiva maschile significa relativizzare la violenza, giustificandola. E ogni volta che un tribunale “comprende” un aggressore, manda alle vittime un messaggio devastante: denunciare non serve.
Queste decisioni non sono solo errori individuali: sono la spia di un sistema che continua a misurare la credibilità delle donne sulla base di parametri morali o estetici. Come osserva la sociologa Pina Lalli nel saggio “L’amore non uccide”, il linguaggio della giustizia “non è mai neutro: è impregnato di una cultura che tende a naturalizzare la violenza e a romanticizzare il dominio maschile”.
Lalli sottolinea come i media e il discorso pubblico costruiscano la figura dell’uomo violento come “innamorato esasperato” o “accecato dalla gelosia”, mentre la vittima viene spesso rappresentata come corresponsabile, imprudente o provocatoria.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) è intervenuta più volte per censurare le distorsioni della giustizia italiana nei casi di violenza di genere, condannando l’Italia per aver violato la dignità delle vittime attraverso stereotipi sessisti e per l’inerzia delle autorità nel proteggerle. Tra le sentenze chiave si possono citare diversi casi che hanno condannato lo Stato per non aver adeguatamente tutelato le vittime di violenza domestica.
Nel 2021, nel caso J.L. c. Italia, la Corte condannò lo Stato per aver utilizzato, in un processo di stupro, espressioni umilianti verso la vittima e per aver dato rilievo alla sua vita sessuale pregressa, violando gli articoli 3 e 8 della Convenzione (divieto di trattamenti degradanti e diritto al rispetto della vita privata).
Nel 2023 l’Italia è stata nuovamente condannata per l’inerzia delle autorità nel proteggere una donna vittima di violenza domestica, in violazione dell’articolo 2 (diritto alla vita), in linea con precedente caso come Talpis c. Italia (2017).
A questi si aggiunge la recente sentenza Scuderoni c. Italia (2025), riguardante una donna vittima di violenza domestica e l’inerzia delle autorità italiane.
La Corte di Strasburgo ha riconosciuto la violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione (divieto di trattamenti degradanti e diritto al rispetto della vita privata), rilevando che i tribunali italiani non avevano valutato tempestivamente il rischio di ulteriori violenze né garantito un’adeguata protezione. I giudici hanno sottolineato che la violenza domestica è una grave violazione dei diritti delle donne e che gli Stati devono agire “con particolare diligenza”, come richiesto dalla Convenzione di Istanbul.
Queste sentenze mostrano che il problema non è episodico, ma sistemico: espressione di una cultura giudiziaria che continua a confondere il diritto con la morale e a ridurre la violenza a “malintesi sentimentali”. Ma ciò che accade nelle aule di giustizia è il riflesso di un paradigma culturale più ampio, radicato nel linguaggio e nei modelli sociali che plasmano la percezione della violenza.
Per questo, la battaglia contro la violenza di genere non può limitarsi al piano giudiziario: è anche una battaglia culturale e linguistica, che deve attraversare la scuola, i media, i luoghi di lavoro e le istituzioni. Solo un cambiamento profondo, capace di modificare il modo in cui raccontiamo e giudichiamo la violenza, potrà restituire centralità alla libertà e al consenso. E’ necessario spostare lo sguardo dalla “credibilità della vittima” alla responsabilità dell’autore, dalla presunta “provocazione” alla reale violazione dei diritti fondamentali della persona.
La CEDU, la Convenzione di Istanbul e le norme internazionali indicano la direzione: la violenza contro le donne non è un fatto privato, ma una violazione dei diritti umani fondamentali.
Solo quando la giustizia abbandonerà il linguaggio del sospetto e della morale per parlare quello dell’uguaglianza, potremo davvero dire – utilizzando le parole di Pina Lalli – che “l’amore non uccide, ma la cultura del possesso sì”.