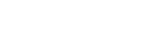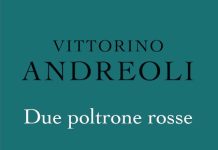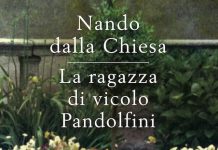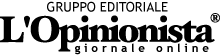Sherlock & Olmo. La morte di Mascia Maria non è solo un giallo. È una riflessione sulla complessità della verità e sulla natura stessa della narrazione. Gennaro Battimo costruisce un’indagine che si sviluppa più attraverso il confronto tra i personaggi che tramite la ricerca di prove concrete.
L’amicizia tra Nicola e Loredana, il rapporto tra Sherlock e il suo lavoro investigativo, la presenza silenziosa di Mascia Maria come enigma da decifrare: tutto contribuisce a un racconto che sfida la linearità tipica del genere. In questa intervista esploriamo con l’autore il suo rapporto con la scrittura e il modo in cui la letteratura può raccontare la realtà senza cadere nella rigidità del bianco e nero.
Buongiorno Gennaro, grazie per aver accettato di fare due chiacchiere con noi. Nel romanzo la verità appare come qualcosa di mutevole, un concetto che cambia a seconda di chi lo racconta. Quanto è importante per lei questo aspetto? Crede che la narrativa debba fornire risposte o porre domande?
Buongiorno. Non vorrei esser noioso già alla prima domanda, eppure, ascoltandola, la memoria corre all’indietro, quando al liceo studiammo che i primi libri di storia erano gli “annales” – che avevano il compito di raccontare le gesta valorose dell’esercito romano a chi viveva a Roma (allora non esisteva il TG, né tantomeno i social). Ma la storia è sempre stata narrata secondo il punto di vista e la verità di chi scrive. È sempre stato così. La storia – e quindi la verità – la scrive il vincitore; io ho sempre l’ambizione, coi miei figli come coi miei allievi, di indurre al ragionamento, di vedere la storia (cosi come un singolo episodio della vita quotidiana) da più punti di vista, per cercare di coglierne la verità. Tornando alla sua domanda, quindi, la narrativa può stimolare a pensare, ma le risposte devono essere ricercate dal singolo lettore.
Mascia Maria è una presenza costante, eppure la conosciamo solo attraverso le parole degli altri. Quanto è difficile costruire un personaggio attraverso ciò che viene detto di lei? Questa scelta narrativa riflette un’idea più ampia sulla memoria e sulla percezione che abbiamo delle persone che non ci sono più?
Mascia Maria era per me una scusa per poter parlare e raccontare delle donne che si danno da fare (e devono farlo molto più degli uomini) per conquistarsi uno spazio nella società; e comunque per vivere la propria. La memoria mi ha permesso di attingere a una mia compagna universitaria, trovata una mattina senza vita nel suo letto dalle compagne con cui divideva l’appartamento a Pisa. Il nome naturalmente è totalmente fantasioso: almeno così pensavo. Lo pensavo fino a quando mi ha contattato proprio una signora di nome Mascia Maria, che non conoscevo, ma che aveva saputo del libro.
Il dialogo è uno degli strumenti principali con cui la storia prende vita. Quanto è stato complesso trovare il giusto equilibrio tra naturalezza e funzione narrativa? Quali accorgimenti ha usato per rendere i dialoghi così vivi e credibili?
Per quanto riguarda i dialoghi, sinceramente credo di non aver inventato molto ma di essermi servito della realtà; la maggior parte dei dialoghi che fanno da contorno alla storia principale sono stati “rubati” dalla realtà; dalle telefonate che ricevo dai call center ai dialoghi tra gli utenti della lavanderia (ascoltati sui vagoni dei treni quando viaggiavo).
Il tempo nel romanzo sembra essere elastico: il presente e il passato si fondono, i ricordi emergono senza un ordine cronologico rigido. Come ha lavorato sulla struttura temporale? C’è stata una difficoltà particolare nel gestire questa fluidità?
Il presente e il passato si fondono spesso, ha detto benissimo; i ricordi vengono a galla senza un ordine cronologico preciso, funzionali alle situazioni che si stanno vivendo. Mi succede spesso nella vita di ogni giorno e ho traslato ciò nel romanzo. Ho cercato di ispirarmi (senza raggiungere risultati paragonabili, ovviamente) al sommo poeta che nella Divina Commedia utilizza la tecnica rubata dopo quasi mille anni dalle serie televisive per ipnotizzare lo spettatore e indurlo a vedere il successivo episodio; sviluppando una serie di storie e lasciando alcune di esse interrotte, alimentando nel lettore la curiosità di scoprire come andranno a finire.
Nicola Olmo è un personaggio che osserva molto, ma agisce poco. Lo ha sempre immaginato così?
L’ho sempre immaginato così; perché è in grado di fare l’opposto di quello che faccio io. Parla poco. Non sa quante volte mi sono pentito di aver parlato; di non aver contato fino a 10 prima di aprire bocca col mio interlocutore. Nicola è un personaggio concreto, che risolve ogni situazione; il suo modo di vivere è molto affine al detto degli scout: “non esiste buono o cattivo tempo, ma solo buono o cattivo equipaggiamento”.
La lavanderia, i luoghi della città, gli spazi chiusi e aperti: nel romanzo tutto sembra avere un significato preciso. Quanto conta per lei l’ambientazione? Scrive partendo dai luoghi o sono i personaggi a definire gli spazi della narrazione?
Tutto è partito dalla lavanderia a gettoni, che è un posto reale che frequentavo trenta anni fa; luogo ideale per ambientare il romanzo dove il mio protagonista doveva interagire con tante persone; dopo aver escluso il prete e il parrucchiere, non ho trovato mestiere migliore per il protagonista. Più in generale, i posti di cui racconto nel mio romanzo provengono dal ricordo dei tempi del liceo, in Campania (Napoli, San Giorgio a Cremano, Portici; Monteforte irpino); e dei tempi dell’università in Toscana ( Pisa, Tirrenia). Anche nella scelta dei luoghi, a far da sottofondo è stata una sottile e costante vena di nostalgia.
Il suo stile è essenziale, eppure capace di evocare molto più di ciò che è scritto sulla pagina. Questo modo di scrivere è frutto di un’elaborazione consapevole o di un’attitudine naturale?
È verissimo; sono stato essenziale per offrire al lettore la possibilità di dare sfogo alla propria immaginazione; di immaginare Nicola alto oppure basso, Sherlock magro oppure grasso, Loredana bionda oppure mora, Mascia Maria in tuta da ginnastica oppure in vestiti eleganti. Soprattutto, mi sono preoccupato affinché ogni lettore potesse avere il proprio tempo per interpretare ciò che avrebbe letto: ognuno a suo modo.
Il rapporto tra Nicola e Loredana è denso di non detti, di confidenze a metà. Ha voluto rappresentare una forma di amicizia diversa dalle solite rappresentazioni letterarie? E che cosa rappresenta per lei l’amicizia?
È un’amicizia dove le parole contano per sentirsi vicino, ma a volte sono inutili o superflue per capirsi. Due persone che hanno avuto la possibilità di conoscersi ai tempi del liceo, ma non la hanno sfruttata; dopo anni si incontrano nuovamente, grazie ai social, e questa volta l’opportunità la sfruttano. A distanza di oltre 500 km sono più vicini di due persone divise da un tavolino e due birre. Si capiscono, si rispettano, gioiscono per le cose belle successe all’altro, sono tristi per le cose brutte capitate all’altro, sono pronti ad aiutarsi reciprocamente. Ho semplicemente raccontato che cos’è per me l’amicizia. Questa è per me l’amicizia.
Se le chiedessimo di individuare tre aggettivi che descrivano appieno il suo romanzo e lo riassumano, quali sarebbero e perché?
Questa è la domanda più difficile; chiedo l’aiuto da casa, e per rispondere leggo i messaggi ricevuti dai lettori dai quali ho avuto riscontro. Ironico: perché regale sorrisi, e a volte risate. Intenso, aggettivo che è stato attribuito sia ai rapporti umani descritti sia alla potenza dei ricordi. Intimo, perché spesso i personaggi non hanno paura di mettersi a nudo. Svelano sé stessi, quasi senza pudore.