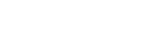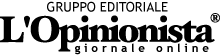Dal Rendiconto sociale 2024 del CIV-INPS emerge un’Italia ancora sbilanciata: donne più precarie, meno pagate e con pensioni più basse, mentre maternità e part-time restano trappole occupazionali

Dietro i numeri incoraggianti sull’occupazione complessiva, con un tasso in crescita al 62,2% e disoccupazione in calo al 6,5%, si nasconde infatti una realtà diseguale, dove le donne restano ancora ai margini del lavoro stabile, ben retribuito e tutelato.
I dati del CIV sono inequivocabili: le donne lavorano meno, vengono assunte meno e guadagnano nettamente meno degli uomini. Nel settore privato, la retribuzione media giornaliera nel 2023 è stata di 107,5 euro per i maschi contro 79,8 euro per le femmine. Il divario si allarga nei comparti a più alta specializzazione — 216,7 euro per gli uomini contro 147,3 per le donne nelle attività finanziarie e assicurative — ma resta marcato anche nei settori più popolari come commercio (92,3 contro 79,9) o ristorazione (65,6 contro 54,9).
Queste differenze non si spiegano solo con il tipo di lavoro, ma con una persistente segregazione occupazionale. La struttura del mercato del lavoro italiano è ancora plasmata su un modello “androcentrico”: le donne sono sovrarappresentate nei settori della cura, dell’assistenza e dell’istruzione, ambiti meno retribuiti e più esposti al rischio psicosociale.
Altro nodo strutturale è quello delle forme occupazionali femminili. Il CIV-INPS evidenzia una netta prevalenza di contratti part-time e discontinui tra le donne.
Non si tratta di una libera scelta: come più volte denunciato anche dall’INAIL e da studi recenti sul rischio di genere, la riduzione dell’orario di lavoro è spesso la sola strategia possibile per conciliare occupazione e carichi familiari. Le donne continuano a farsi carico in misura sproporzionata del lavoro di cura e, quando diventano madri, il prezzo pagato è altissimo: carriere interrotte, retribuzioni bloccate, progressioni di ruolo congelate.
Il ricorso al congedo parentale ne è la prova più evidente. Le donne lo utilizzano in misura di gran lunga superiore agli uomini che, in Italia, rappresentano ancora una minoranza residuale tra i fruitori di queste misure. È una “asimmetria della cura” che si traduce in un doppio svantaggio: penalizzazione immediata sul reddito e prospettiva pensionistica più povera in futuro.
Le disuguaglianze di genere non si esauriscono nel mercato del lavoro ma si amplificano nella fase post-lavorativa. Il Rendiconto sociale 2024 evidenzia una differenza drammatica negli importi pensionistici: le pensioni di vecchiaia delle donne risultano inferiori del 44,2% rispetto a quelle degli uomini, e quelle anticipate del 25,1%. Un divario che si alimenta negli anni di carriera: più interruzioni, minore continuità contributiva e stipendi più bassi che si traducono in un reddito da pensione insufficiente a garantire autonomia economica nella terza età.
Le pensionate italiane, pur rappresentando la maggioranza dei titolari (7,9 milioni contro 7,3 di uomini), sono più numerose ma più povere.
Il tema economico si intreccia con quello sociale e culturale. La condizione di svantaggio femminile si accompagna spesso a fenomeni di molestie, mobbing e violenza nei luoghi di lavoro, che costituiscono una barriera ulteriore all’uguaglianza. Secondo i dati INAIL, nel 2023 oltre 6.800 infortuni derivavano da aggressioni o violenze, con un incremento del 14,6% tra le lavoratrici, contro il 3,8% tra gli uomini. La maggior parte dei casi si concentra nei settori ad alta femminilizzazione — sanità, assistenza, istruzione — a conferma di una correlazione tra vulnerabilità occupazionale e rischio psicosociale.
La sociologia del lavoro parla di “violenza simbolica”: un insieme di pratiche quotidiane che relegano la donna a ruoli subordinati, normalizzando diseguaglianze e abusi con un mercato del lavoro che resta strutturato su un modello maschile, pensato per chi non deve scegliere tra lavoro e famiglia. Le cause di questo squilibrio sono molteplici e radicate. Da un lato, una cultura del lavoro ancora ostile alla piena parità, dove stereotipi e discriminazioni sottili frenano la carriera femminile. Dall’altro, una carenza di politiche di welfare e di servizi per l’infanzia e la non autosufficienza, che costringe le donne a ridurre o interrompere l’attività lavorativa. Le misure di conciliazione restano episodiche, mentre l’uso del part-time involontario continua a salire. Tra gli strumenti di sostegno più recenti va ricordato il Nuovo bonus mamme, introdotto dal decreto-legge 95/2025.
Si tratta di un’integrazione al reddito rivolta alle lavoratrici madri con due o più figli, che prevede un’erogazione di 40 euro al mese per ogni mese di lavoro svolto nel 2025, fino a un massimo di dodici mensilità. Il bonus, non imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rilevante ai fini ISEE, è riconosciuto a domanda alle madri con reddito annuo da lavoro non superiore a 40.000 euro.
Una misura che, sebbene modesta, rappresenta un segnale di attenzione verso le difficoltà di conciliazione che ancora penalizzano le madri lavoratrici, in un Paese dove il costo della maternità resta in larga parte privato e invisibile.
Non mancano tuttavia segnali di consapevolezza e di risposta. L’INAIL ha introdotto la “valutazione dei rischi in ottica di genere” e il legislatore ha rafforzato gli strumenti di tutela con la certificazione della parità di genere (Legge 162/2021), che premia le aziende impegnate in politiche inclusive e di prevenzione delle discriminazioni. Anche i Comitati Unici di Garanzia (CUG) nella pubblica amministrazione stanno assumendo un ruolo più incisivo nel monitoraggio del benessere organizzativo e nel contrasto alle molestie.
Ma per invertire la rotta serve un salto culturale, prima ancora che normativo: riconoscere la maternità come valore sociale e non penalità, garantire la parità salariale come diritto esigibile, promuovere una cultura del rispetto che attraversi scuole, aziende e istituzioni.
Il Rendiconto sociale 2024 del CIV-INPS è, in definitiva, lo specchio di un’Italia che cambia troppo lentamente. L’aumento dell’occupazione non basta se resta confinato a lavori fragili e sottopagati. La crescita del PIL perde significato se non si traduce in una redistribuzione equa delle opportunità.
Le donne italiane continuano a sostenere il Paese con lavoro, cura e resilienza, ma ricevono in cambio meno salario, meno sicurezza e meno pensione.
La sfida dei prossimi anni sarà dunque trasformare l’equità di genere da obiettivo etico a necessità economica e democratica. Solo così il lavoro femminile potrà smettere di essere il termometro della disuguaglianza e diventare, finalmente, la misura della modernità del Paese.