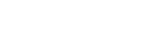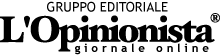Il dualismo, l’opposizione tra le diverse nature di un individuo è la chiave di lettura di molti artisti contemporanei che mostrano nelle loro opere la tendenza a lasciar emergere tutte le loro anime espressive, quasi come se raccontare una sola caratteristica del sé non fosse sufficiente a mostrare quelle sfaccettature che li inducono al processo creativo. In questi particolari casi la libertà di poter fondere e unire linguaggi o interpretazioni stilistiche differenti tra loro, nella loro veste originaria, permette a questo tipo di autori di attenuare o accentuare alcune linee guida adattandole alle proprie caratteristiche narrative. Questo è il caso dell’artista, o per meglio dire lo scultore, di cui vi parlerò oggi, in cui la schematicità trova un ammorbidimento grazie all’utilizzo di tonalità inconsuete eppure perfettamente armonizzabili proprio agli schemi entro in quali si esprimono.
Nel momento in cui nacque una predilezione da parte degli artisti per un distacco ben deciso da tutta l’arte figurativa e riferita alla realtà osservata che aveva contraddistinto i secoli precedenti, gli avanguardisti dell’Arte Astratta si trovarono davanti a un bivio: da un lato ci fu infatti la morbidezza emozionale, legata all’ascolto della musica e all’associazione dei colori alle note classiche, dall’altro il rigore determinista e assolutamente lontano da ogni soggettivizzazione da parte degli autori delle opere. L’attitudine più rigorista iniziò con il Suprematismo di Kazimir Malevič, dove l’astrazione entrò nel mondo della forma geometrica seppure obliqua e quasi scomposta, e contraddistinta da colori pieni e piatti su basi bianche, a cui fece sponda, dalla parte opposta dell’Europa e precisamente nei Paesi Bassi, la rigidezza lineare di Piet Mondrian e Theo van Doesburg che tuttavia con il loro De Stijl ripudiarono l’ambiguità e la fragilità delle linee oblique e circolari per accettare solo la stabilità del quadrato e del rettangolo, optando altresì per un estremismo cromatico in cui erano inclusi solo i colori primari, e dunque il bianco, il nero, il giallo, il rosso e il blu.
Ben presto quel tipo di percorso cominciò a mostrare i suoi limiti poiché le possibili combinazioni non solo si esaurirono velocemente, ma anche perché Theo van Doesburg comprese che sarebbe stato necessario una maggiore poliedricità per riuscire a coinvolgere maggiormente l’osservatore; a quel punto la rottura con l’ostinato Mondrian fu obbligata e il cofondatore del movimento cominciò ad avvicinarsi in maniera via via più evidente alla nuova interpretazione dell’Astrattismo Geometrico che stava nascendo nel Nord Italia e che ebbe come principali scuole la galleria Il Milione di Milano e la Scuola di Como. La geometricità bidimensionale accolse dunque nuove forme e nuovi colori, trasparenze e sovrapposizioni come nelle tele di Manlio Rho e di Luigi Veronesi, il quale cominciò a introdurre anche le proiezioni e la prospettiva gettando le basi per il successivo percorso visivo sperimentale della Op Art che vide tra i protagonisti un altro immenso interprete della vivacità cromatica, l’ungherese Victor Vasarely. Fu tuttavia Van Doesburg, nel momento in cui venne chiamato come docente nella prestigiosa e innovativa Bauhaus di Weimar ad applicare per primo le linee guida modificate e adattate al suo percorso creativo, ormai distante da quello di Piet Mondrian, ai progetti architettonici che erano alla base della scuola d’avanguardia e che mostrarono possibilità inedite di applicazione della filosofia del De Stijl a una tridimensionalità che fino a poco prima era stata esclusa categoricamente ma che in realtà perfettamente si adattava alle linee architettoniche del Razionalismo, stile di costruzione prediletto dalla scuola tedesca. È proprio ai progetti di Van Doesburg arricchiti da una vitalità cromatica coinvolgente e solare che attinge la nuova produzione scultorea del tedesco Hans Adam, interprete contemporaneo di un Astrattismo Geometrico che sa andare oltre gli schemi per mostrare quanto in fondo sia infinitamente più piacevole prendersi sul serio solo a metà, quanto sia efficace e coinvolgente per il fruitore sentirsi rassicurato dalla forma solida e rigorosa ma poi lasciarsi andare alle possibilità di un colore che corrisponde alla vita stessa.

La sua natura sperimentatrice non si ferma però alla mescolanza tra rigore formale e morbidezza coloristica bensì, allo stesso modo in cui alla Bauhaus si cercava di applicare conoscenze artigiane all’arte e viceversa, si avvale di materiali spesso non considerati per essere inclusi nella scultura, come il cartone e il plexiglas che aggiunti al legno, alla vernice e alla pittura riescono a creare figure apparentemente solide ma di fatto leggere, rigide eppure evocanti un possibilismo esistenziale che colpisce e conquista lo sguardo.

Hans Adam suggerisce attraverso la sua nuova produzione quanto l’essere umano moderno sia costretto a crearsi dei piedistalli, delle corazze consistenti che tuttavia nascondono un interno fragile, una ricerca costante di equilibrio tra ciò che deve apparire all’esterno e ciò che invece è un’interiorità molto più ricca e per questo a rischio di essere ferita.

Le sculture geometriche sono dunque costantemente in bilico, mostrano una fermezza precaria, quasi come se si sforzassero costantemente di mantenersi salde in un mondo in cui tutto può crollare da un momento all’altro, e così l’unica via è quella di mostrare il sorriso, la solarità, l’ironia, che fuoriescono da una gamma cromatica insolita, se riferita all’Astrattismo Geometrico, e che sottolineano il dualismo espressivo e caratteriale che contraddistingue l’autore. Alla leggerezza del cartone e delle sottili strutture in legno, si somma così anche quella di tonalità come il celeste chiaro, il lilla, il verde mela, e l’alternanza tra vuoti e pieni generata dal plexiglas, degli scheletri in legno che rendono le sculture, anche le più alte, incredibilmente affascinanti per la loro esilità.

Utopia è una composizione che sembra imitare la bellezza di un fiore fortemente stilizzato e al contempo riprende il tema dei vuoti e dei pieni tanto tipico della produzione di Hans Adam; le differenti tonalità alternate definiscono le facce dei cubi che compongono quello più grande, evocando l’immagine del celeberrimo Cubo di Rubik che tanto ha impegnato la mente e l’abilità di giovani e meno giovani negli anni Ottanta del Novecento. L’opera è ferma nel momento della rotazione, quasi lo scultore volesse sottolineare le infinite possibilità che appartengono all’esistenza stessa, di cui in questo caso il cubo è metafora, e che possono dare molteplici punti di vista sulla base delle circostanze e delle casualità che si verificano.

L’opera Würfel auf Spiegel (Cubo sullo specchio) presenta una struttura molto fragile, trasparente, costituita da bacchette di legno variopinte che poggiano su una piramide fatta di specchio e sorretta, in questo caso, da una base molto solida, quasi una colonna in stile razionalista, che si contrappone all’ariosità della composizione, come se Hans Adam volesse evocare l’effetto di rifrazione della luce che nasce in presenza di uno specchio. L’effetto ottico e di grande ariosità conquista per la leggerezza e al contempo per la cromaticità delicata delle piccole stecche intrecciate tra loro che sembrano allegoria delle infinite emozioni, pensieri e sensazioni che avvolgono la testa e l’anima dell’individuo; oppure sono idee che per manifestarsi trovando il loro ordine caotico, hanno bisogno di essere sorrette dalla concretezza costituita dal piedistallo.

La scultura Ein Würfel (Un cubo), a dispetto del titolo, è invece una proiezione immaginaria dell’oggetto a cui fa riferimento, enfatizzando ancora una volta la tendenza di Hans Adam a sovvertire le regole, a creare confusione dove la razionalità vorrebbe trovare ordine, e in qualche modo ironizza, gioca con l’osservatore che è chiamato a dare un senso più profondo a ogni opera dell’artista. Le punte che si spingono verso l’esterno quasi a cercare compiutezza geometrica nello spazio circostante sono incomplete tanto quanto lo è l’individuo che non riesce a lasciar emergere tutti i lati di sé, pertanto l’esortazione è quella di non prendersi troppo sul serio e di permettere alla fantasia di entrare anche in un mondo tanto rigoroso quanto quello della mente che tutto vorrebbe dominare. Di fatto l’unico vero cubo di questa composizione è la base, quella che sorregge l’opera e che mostra quanto in fondo la realtà sia sempre una questione di punti di vista. Qui non esiste una faccia di quella strana figura che abbia lo stesso colore di un’altra, proprio per ricordare che la coesistenza di visioni divergenti può essere la risorsa maggiore che l’umanità abbia.

Anche Drei durch eins (Tre in uno) ha il medesimo approccio aperto alla diversità che però non impedisce di considerare l’importanza del fondersi insieme esattamente in virtù di differenze che divengono ricchezza perché possono dare vita a forme, pensieri, considerazioni che solo grazie al confronto positivo e dialogante danno un senso diverso a tutte le convinzioni precedenti; la gamma cromatica si fa di nuovo sfaccettata eppure le tonalità in questo caso sono meno pastello, più piene per evidenziare la preziosità di quella fusione di personalità figurative differenti. Hans Adam si è formato presso l’Università di Scienze Applicate di Colonia, è membro di molte associazioni culturali e artistiche tedesche, ha al suo attivo la partecipazione a mostre collettive e personali in Germania e all’estero – Italia, Lussemburgo, Francia e Austria – ed è inserito in importanti annuari d’arte tra cui l’Atlante dell’Arte Contemporanea Met Edition edito da Giunti.
HANS ADAM-CONTATTI
Email: hans_adam@gmx.de
Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=61562866640542
Instagram: www.instagram.com/hansadam_24/
The contrast between rigor and chromatic vividness in the Geometric Abstractionism by Hans Adam
Dualism, the opposition between the different natures of an individual is the key to understanding many contemporary artists who show in their works the tendency to let emerge all their expressive souls, almost as if telling only one characteristic of the self was not enough to show those facets that lead them to the creative process. In these particular cases, the freedom of being able to merge and combine different languages or stylistic interpretations in their original guise allows these types of authors to attenuate or accentuate certain guidelines by adapting them to their own narrative characteristics. This is the case with the artist, or rather the sculptor, whom I will tell you about today, where schematicism finds a softening through the use of unusual tones yet perfectly harmonizable precisely to the patterns within which they express themselves.
At the moment when arose a predilection on the part of artists for a definite detachment from all figurative art and referring to observed reality that had distinguished the previous centuries, the avant-gardists of Abstract Art found themselves at a crossroads: on the one hand there was in fact the emotional softness, linked to listening to music and the association of colors with classical notes, on the other the determinist rigor and absolutely far from any subjectivization on the part of the authors of the artworks. The more rigorist attitude began with Kazimir Malevič‘s Suprematism, where abstraction entered the world of geometric form, albeit oblique and almost decomposed, and distinguished by solid, flat colors on white bases, to which it was backed, on the opposite side of Europe and precisely in the Netherlands, the linear rigidity of Piet Mondrian and Theo van Doesburg, who nevertheless with their De Stijl repudiated the ambiguity and fragility of oblique and circular lines in order to accept only the stability of the square and rectangle, opting also for a chromatic extremism in which were included only the primary colors, and thus white, black, yellow, red and blue.
Soon that kind of path began to show its limits as the possible combinations not only quickly ran out, but also because Theo van Doesburg understood that would be necessary a greater polyhedrality to succeed in more engaging the viewer; at that point the break with the obstinate Mondrian was obligatory and the co-founder of the movement began to move gradually closer to the new interpretation of Geometric Abstractionism, which was emerging in northern Italy and which had as its main schools the Il Milione gallery in Milan and the School of Como. Two-dimensional geometricity thus welcomed new forms and new colors, transparencies and superimpositions as in the canvases of Manlio Rho and Luigi Veronesi, who also began to introduce projections and perspective, laying the foundations for the later experimental visual path of Op Art that saw among its protagonists another immense interpreter of chromatic vivacity, the Hungarian Victor Vasarely.
It was Van Doesburg, however, at the time he was called as a lecturer in the prestigious and innovative Bauhaus in Weimar who first applied the modified and adapted guidelines to his own creative path, now far removed from that of Piet Mondrian, to the architectural projects that were the basis of the avant-garde school and that showed unprecedented possibilities for applying the philosophy of De Stijl to a three-dimensionality that until recently had been categorically ruled out but in fact perfectly suited the architectural lines of Rationalism, the German school’s favorite style of construction. It is precisely to the designs of Van Doesburg enriched by an engaging and sunny chromatic vitality that draws the new sculptural production of the German Hans Adam, contemporary interpreter of a Geometric Abstractionism who knows how to go beyond the box to show how infinitely more pleasant it is after all to take oneself only half seriously, how effective and engaging it is for the viewer to feel reassured by solid, rigorous form but then to let go of the possibilities of a color that corresponds to life itself.
His experimental nature, however, does not stop at the mixture of formal rigor and coloristic softness; rather, in the same way that the Bauhaus sought to apply artisanal knowledge to art and vice versa, he makes use of materials often not considered to be included in sculpture, such as cardboard and Plexiglas, which when added to wood, varnish and paint manage to create figures that are seemingly solid but in fact light, rigid yet evoking an existential possibilism that strikes and conquers the eye. Hans Adam suggests through his new production how much the modern human being is forced to create for himself pedestals, substantial armor that nevertheless conceals a fragile interior, a constant search for balance between what must appear on the outside and what is instead a much richer interiority and for this reason at risk of being wounded. The geometric sculptures are thus constantly in the balance, showing a precarious firmness, almost as if they were constantly striving to hold firm in a world in which everything can collapse at any moment, and so the only way is to show the smile, the sunshine, the irony, which emerge from an unusual chromatic range, if referred to Geometric Abstractionism, and which emphasize the expressive and character dualism that distinguishes the author.
The lightness of cardboard and thin wooden structures is thus also added to that of shades such as light blue, lilac, apple green, and the alternation between empty and full spaces generated by the Plexiglas, wooden skeletons that make the sculptures, even the tallest ones, incredibly fascinating for their slenderness. Utopia is a composition that seems to mimic the beauty of a highly stylized flower and at the same time takes up the theme of voids and solids so typical of Hans Adam‘s production; the different alternating tones define the faces of the cubes that make up the larger one, evoking the image of the very famous Rubik’s Cube that so engaged the minds and skills of young and old in the 1980s. The work is fixed at the moment of rotation, as if the sculptor wanted to emphasize the infinite possibilities that belong to existence itself, of which in this case the cube is a metaphor, and which can give multiple points of view based on the circumstances and randomness that occur.
The artwork Würfel auf Spiegel (Cube on the mirror) presents a very fragile, transparent structure, consisting of multicolored wooden rods resting on a pyramid made of mirror and supported, in this case, by a very solid base, almost a column in the rationalist style, which contrasts with the airiness of the composition, as if Hans Adam wanted to evoke the effect of refraction of light that arises in the presence of a mirror. The optical and airy effect conquers because of the lightness and at the same time the delicate chromaticity of the small slats woven together that seem to be allegories of the infinite emotions, thoughts and sensations that envelop the head and soul of the individual; or else they are ideas that in order to manifest themselves by finding their chaotic order, need to be supported by the concreteness constituted by the pedestal. The sculpture Ein Würfel (A Cube), in spite of its title, is instead an imaginary projection of the object it refers to, again emphasizing Hans Adam‘s tendency to subvert rules, to create confusion where rationality would like to find order, and in some ways he is being ironic, playing with the observer who is called upon to make deeper sense of each of the artist’s works.
The points that push outward almost as if seeking geometric completeness in the surrounding space are as incomplete as is the individual who fails to let emerge all sides of himself, so the exhortation is not to take oneself too seriously and to allow the imagination to enter even a world as rigorous as that of the mind that would like to dominate everything. In fact, the only real cube in this composition is the base, the one that holds up the work and shows how ultimately reality is always a matter of viewpoints. Here there is no face of that strange figure that has the same color as another, just to remind us that the coexistence of divergent views can be the greatest resource humanity has. Drei durch eins (Three in One) also has the same open approach to diversity, which, however, does not prevent from considering the importance of merging together exactly by virtue of differences that become richness because they can give rise to forms, thoughts, considerations that only through positive and dialogical confrontation give a different meaning to all previous convictions; the chromatic range becomes multifaceted again and yet the tones in this case are less pastel, fuller to highlight the preciousness of that fusion of different figurative personalities. Hans Adam trained at the University of Applied Sciences in Cologne, is a member of many German cultural and artistic associations, has to his credit participation in group and solo exhibitions in Germany and abroad – Italy, Luxembourg, France and Austria – and is included in important art directories including the Met Edition Atlas of Contemporary Art published by Giunti.